
Qui sotto troverete la foto di un articolo apparso su “La Gazzetta del Mezzogiorno” il 27 gennaio 2021, nel Giorno della Memoria, a firma della nota scrittrice barese Rita Lopez ed intitolato “Quanti nomi sotto il melo di Jolanta” con il sottotitolo: “La novella: piccoli deportati tratti in salvo dal ghetto grazie ad uno stratagemma”.
Si tratta della vita vera di Jolanta, poi morta in età avanzata, che nel Ghetto di Varsavia, come infermiera e con la sua ambulanza, salva migliaia di bambini. Lo stratagemma cui fa riferimento il titolo consiste nella falsa etichetta di malati di tifo riferita ai bambini (malattia di cui i soldati nazisti avevano terrore), ma anche all’idea di narcotizzare alcune volte i bambini o di attorniarsi di cani che, appositamente addestrati, abbaiassero, il tutto perché i soldati nazisti non sentissero il pianto dei piccoli, i loro lamenti o la loro voce. Dice Rita Lopez in questo racconto struggente di storia vera: ”Ero troppo piccolo perché possa ricordare, oggi, come andarono le cose. Ma io so esattamente come andarono le cose, perché me lo hanno raccontato migliaia di volte. So che era polacca ed era cresciuta in una famiglia socialista e cattolica. So che iniziò prestissimo la sua attività di opposizione alla persecuzione antisemita e per questo fu espulsa per tre anni dall’Università di Varsavia. So che entrò a far parte di una organizzazione clandestina sotto lo pseudonimo di Jolanta”.
Facendo parlare poi in prima persona i bambini salvati, Rita Lopez conclude; “So che l’organizzazione clandestina ci affidava poi a delle famiglie private o a dei conventi, con documenti falsi e nomi cristiani. So che Jolanta annotò i nostri nomi su dei bigliettini. Un bigliettino per ciascuno di noi con il nome vero e quello falso. Perché un giorno potessimo ricongiungerci alle nostre famiglie”.
Quindi, a proposito dell’eccidio degli Ebrei, la Lopez riporta una storia vera tramandata attraverso il racconto “perché l’ho sentito questo racconto migliaia di volte”, come la storia vera dell’eccidio del Ghetto di Varsavia raccontata ne “La Lista di Schindler”, sublimata al cinema nell’omonimo capolavoro di Steven Spielberg, di cui abbiamo riportato in copertina l’immagine più famosa, quella dell’anonima bambina con il cappotto rosso.
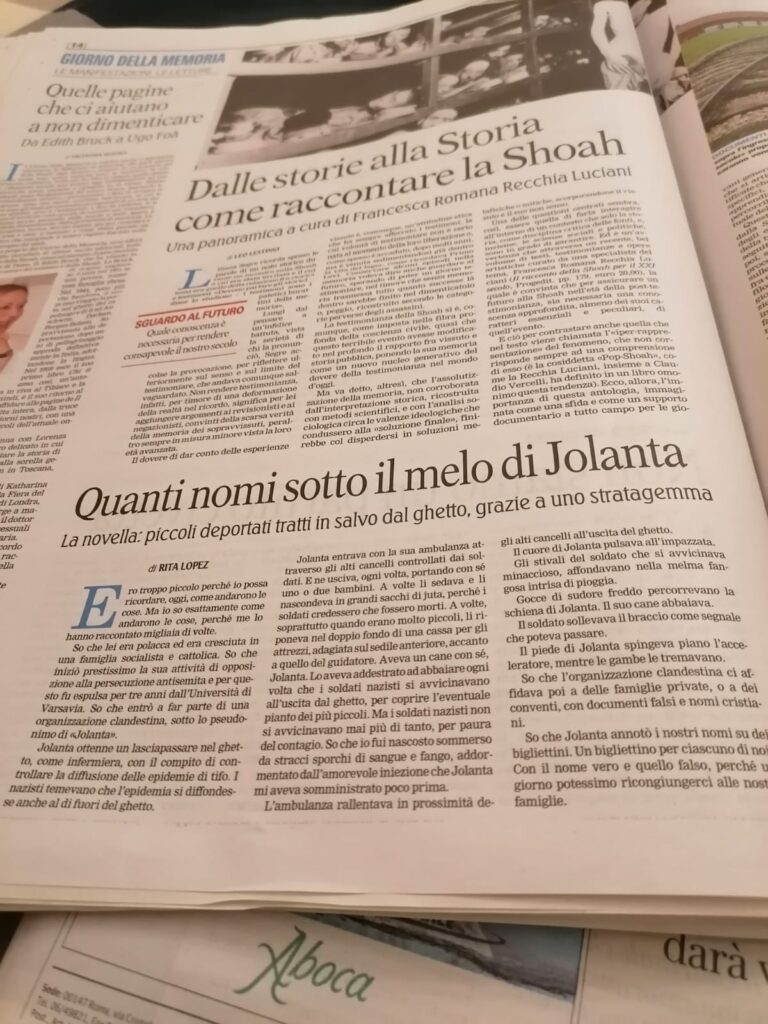
Ma cosa c’entra tutto quello che ho detto con il tema del nostro articolo, con gli Ebrei a Bari? Abbiate la pazienza di seguirmi in questo mio viaggio nella memoria e lo scoprirete.
Perché alla storia vera (quella documentata e tuttora riscontrabile), si aggiunge un’altra storia, anche essa vera, non documentata e non più documentabile, pervenuta attraverso i racconti veri e non romanzati dei nostri genitori, dei nostri parenti e, ormai, anche di chi scrive, nato nel gennaio 1944. Insomma, la memoria storica, che ha anche essa la medesima dignità della storia ufficiale.
(E qui apro una piccola parentesi e faccio riferimento ai miei professori del Liceo Classico Flacco di Bari a cavallo degli anni ’50-’60 (1958-1963), i professori Michele D’Erasmo e Renato Scionti, i quali insegnarono a me e ai miei compagni di scuola che dietro l'”Obbedisco” di Garibaldi a Teano nell’incontro con il Re Vittorio Emanuele II, c’erano una serie di bestemmie e quali bestemmie, qual si addicevano al carattere effervescente e inquieto di Giuseppe. Dicevano i miei professori che l’incontro non finì, come si suol dire, a tarallucci e vino, ma dopo un lite violenta tra i due uomini.)
E allora sulla base di una storia non documentata ufficialmente, ma verissima nei suoi contenuti essenziali, assolutamente non romanzati, comincia la storia di Bari e gli Ebrei, che io riferirò in quel microcosmo (a far tempo dal dopoguerra fino a quasi la fine degli anni ’50) rappresentato dal Quartiere Carrassi dove simboleggiavano, come le strade americane, la 1^ strada (= Via Pasubio), la 2^ strada (= Via Isonzo), la 3^ strada (= Via Montegrappa) e la 4^ strada (= Via Piave) dove io sono nato nel gennaio 1944.
Erano queste strade perpendicolari a Corso Sicilia, attualmente Via Benedetto Croce, nella sua prima parte per poi chiamarsi Corso Alcide De Gasperi nella seconda parte verso Carbonara dove si tramuta in Via De Marinis. Corso Sicilia aveva sulla sua sinistra andando verso Carbonara, la ferriera per il tram che veniva da Carbonara per andare a Bari (come si diceva all’epoca) e viceversa. Su Corso Sicilia ci sono ancora: la Scuola Elementare Carlo del Prete, la Chiesa Russa, l’Istituto Margherita (dove accedevano dalle elementari in poi solo le ragazze, nessun maschio come oggi), la Chiesa dei Padri Carmelitani (poi diventata Parrocchia unitamente alla Parrocchia di Via Pasubio), il Carcere, cui si aggiunse poi sulla Via Giulio Petroni il Carcere dei Minorenni. Non ci sono più, a partire dall’attuale Extramurale Capruzzi, il Saponificio Borrelli, il Cinema Adriatico, la Vetreria Pizzirani, l’adiacente Campo degli Sports dove giocava in serie “A” la Bari, la Vetreria Bournique in Via Pasubio.
Il Rione Carrassi di fatto terminava in Via Sabotino dove troneggiava lateralmente l’Istituto Margherita. Poi dopo, il carcere con adiacente l’ancora esistente Palazzo Cappelluti, Via Podgora e poi Monte San Michele dove questi luoghi prendevano genericamente il nome di Padreterno.
Che Bari in quegli anni fosse la più grande città europea (e non solo Bari, ma tante altre località della Puglia) che abbia accolto il più alto numero di ebrei scampati dalla strage nazista di tutti i paesi europei, è storia documentata, soprattutto dal prof. Vito Antonio Leuzzi il quale riferisce quanto segue: “«L’evento certamente più notevole fu la fondazione di una comunità israelitica a Bari, la prima nella storia recente di questa città, dove la presenza di ebrei era assai scarsa. Già alla fine del 1943 venne ricostruito un consiglio provvisorio della comunità». Così lo storico berlinese Klaus Voigt, nel volume “Il rifugio precario (1993)” ricostruiva le drammatiche vicende degli ebrei che riuscirono a trovarono accoglienza nel capoluogo pugliese e nel resto della regione in un dopoguerra anticipato rispetto al resto del Paese. All’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 gli ebrei liberati dai campi di internamento fascisti, disseminati nel Meridione, si diressero verso una regione che dalla fine di settembre, liberata dai tedeschi, si trovava sotto il controllo militare degli alleati anglo-americani. In una situazione per certi versi unica nel contesto europeo iniziarono infatti ad affluire a Bari, anche dall’altra sponda dell’Adriatico, ebrei jugoslavi e di diverse altre nazionalità, in fuga dal terrore nazista che dilagava nella penisola balcanica. Gli alleati allestirono alla periferia di Bari, nella frazione di Carbonara, a Torre Tresca, un grande campo profughi, avvalendosi delle baracche di un ex campo di concentramento militare per prigionieri di guerra. Nella struttura del capoluogo pugliese, sostiene ancora Voigt, «i profughi venivano registrati, liberati dai parassiti, visitati da medici, curati quando era necessario e riforniti di abiti. A Bari oltre al reparto per la quarantena, vi era una zona del campo destinata ad accogliere i profughi per un soggiorno più lungo». Il campo di Torre Tresca definito, «Transit Camp n. 1», non fu sufficiente a contenere il grande afflusso di rifugiati. Furono requisiti alcuni appartamenti nel centro della città e molti ebrei trovarono occupazione nelle diverse strutture di servizio alleate, come interpreti, traduttori stenodattilografi e in attività artigianali e commerciali. Con il sostegno dell’Unnra (organizzazione delle Nazioni Unite) si iniziarono ad allestire altri campi profughi a Gravina–Altamura e nell’area Salentina, Santa Maria al Bagno, Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea e Tricase. La presenza ebraica si consolidò con l’arrivo nel gennaio ’44 di una unità della Brigata ebraica-palestinese che iniziò a svolgere un’opera assistenziale per i profughi, considerate le loro condizioni di vita precarie dopo anni di persecuzione e di terrore. In questo contesto si costituì inizialmente «un centro ebraico di accoglienza» collocato nel quartiere murattiano, in uno stabile di via Garruba 63, costituito da due uffici che rispondeva alle richieste di aiuto. Nel corso del 1944 sorse «la Comunità israelitica» con la messa a disposizione dell’ammezzato e l’intero primo piano dell’edificio collocato ad angolo tra via Garruba e via Quintino Sella che includeva venti vani. Un ruolo rilevante fu svolto dalla Comunità israelitica di Bari nelle vicende relative alla lotta antinazista in Italia e nella penisola balcanica. Diversi ebrei italiani e di diverse nazionalità, ospitati prima nel campo Transit n.1 di Bari e poi in quello di Gravina, si arruolarono nelle brigate d’Oltremare, a sostegno della liberazione iugoslava”.

Focalizzo qui l’attenzione su alcuni luoghi e attività: 1)- Luoghi; periferia di Bari e Carbonara, Torre Tresca e Via Garruba-Via Q.Sella; 2)- Attività: i profughi venivano registrati, liberati dai parassiti, visitati da medici, curati quando era necessario e riforniti di abiti.
In questo contesto colloco la storia del Quartiere Carrassi e di Via Piave in particolare, dove sono nato, in relazione all’aiuto umano e sostanziale dato da alcuni uomini straordinari, persone, professionisti di prestigio e di alto valore umano e professionale in favore degli ebrei soprattutto alloggiati a Torre Tresca, Carbonara e Bari Centro (Via Garruba-Via Q.Sellla).
Sono:
1)- il dr. Nicola Oberdan Laforgia, medico internista con abitazione e studio in Bari alla Via Garruba n. 3;
2)- il dr. Felice Jelpo, medico anche lui, specializzato in ostetricia e ginecologia con studio e abitazione in Carrassi in una palazzina ad un piano credo di Via Piave n. 86 o 88 dove aveva studio e abitazione;
3)- L’avv. Francesco Muciaccia, Don Ciccio, che aveva studio e abitazione all’ultimo piano di Largo Adua n. 24, comunista, noto per le battaglie in favore dei braccianti e in Puglia, braccio destro di Di Vittorio.
Questi immobili ancora esistono.
La conoscenza e la storia di questi tre grandi uomini deve essere da me raccontata per quel poco che ho cominciato a comprendere dal 1951 in poi quando avevo 7 anni, e da quello che mi hanno raccontato;
a)- mio padre Umberto nato il 1911;
b)- mia madre Angela Rossini nata il 1915;
c)- mia zia Lucia Loseto, che era la sorellastra di mio padre al quale voleva molto bene, che lo ha cresciuto come un figlio e che era proprietaria dell’intero immobile sito in Via Piave al n. 11 (immobile tuttora esistente);
d)- i suoi figli e miei cugini Anna e Vittorio Loseto;
e)- di mia zia materna Teresa Rossini e di suo marito Vito Uva;
f)- i miei zii materni, i Rossini (9 figli rimasti orfani dei loro genitori dal giugno 1944 quando morì mio nonno materno Nicola Rossini, che abitavano tutti in Via Monte San Michele (immobile tuttora esistente);
g)- e infine, per quanto riguarda l’avv. Don Ciccio Muciaccia e marginalmente il dr. Nicola Oberdan Laforgia, mio suocero Michele Schino, proprietario del famoso “Piccolo Bar” all’epoca sito all’angolo di Via Cognetti/Via Abbrescia, nonché proprietario dei ristoranti/dancing dell’epoca “Piccola Nizza” a Torre a Mare e “Capocabana” a Palese, padre di ben 11 figli, abitante al primo piano di Largo Adua n.17, nato il 1904, che per la giovane età non aveva fatto la 1^ guerra mondiale, e per la molteplicità dei figli non aveva partecipato nemmeno alla 2^ guerra mondiale (infatti all’epoca aveva già oltre 5 figli tutti minorenni);
h)- ultimo, ma non meno importante, Il mio amico di ginnasio/liceo e di vita Niki Muciaccia (nato nel marzo 1945 e deceduto nel luglio 2013) per quanto riguarda suo padre avv. Francesco Muciaccia, il tutto riscontrato in gran parte da mio suocero Michele Schino.
Come detto, sono nato il 19 gennaio 1944 a Carrassi in Via Piave n. 58 dove mio padre, nato nel giugno 1911 (all’epoca sergente maggiore della Marina Militare di stanza a Brindisi, poi contabile della Impresa Edile Cervini e poi dagli anni 50 in poi proprietario di un negozio di scarpe sito prima in Via Argiro angolo Corso Vittorio Emanuele poi in Via Melo) era andato ad abitare nel 1936 circa, dopo la cd. “fuitina” con mia madre e che prima di me erano nati mio fratello Vito (il 1 ottobre 1937, primogenito), mia sorella Bruna Maria (11 febbraio 1939, secondogenita), poi mio fratello Nicola credo il 1941 (nato grosso 6 kg e mezzo e poi morto credo a 1 anno circa diceva mia madre “perché era troppo grosso”) e poi io il 19 gennaio 1944 con lo stesso nome del mio fratellino che mi aveva preceduto.
Faccio notare la scansione delle nascite ogni 2 anni. Perché?
Perché all’epoca non esistevano pratiche contraccettive, se non il violento aborto delle mammane, di cui parlerò dopo, sicché terminato grosso modo il periodo di allattamento di 2 anni, le nostre mamme tornavano puntualmente gravide.
A)- Storia personale del Dr. Nicola Oberdan Laforgia: mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello ed io.
Come ho riferito, mio padre, nel dopoguerra, finita l’attività di contabile con l’Impresa Edile Cervini, si mise in proprio e organizzò un’attività commerciale in Via Argiro angolo Corso Vittorio Emanuele in società con mio zio Mario, profugo albanese, che aveva sposato la sorella di mio padre Margherita, una bellissima donna alta, dagli occhi celesti come quelli di mio padre. Trasferitosi in Via Melo quando fu chiuso il negozio di Via Argiro per la prematura scomparsa di zio Mario, mio padre si era industriato vendendo a rate, senza cambiali, scarpe di livello medio/alto e molto resistenti alle intere famiglie dei dipendenti di alcuni enti tramite i rispettivi Cral e Dopolavori, tra cui l’Acquedotto Pugliese, le Ferrovie dello Stato, le Ferrovie Sud-Est, che all’epoca si chiamavano Ferrovie Appulo-Lucane, i Post-Telegrafonici, la SME (Società Meridionale Elettrica, poi confluita in Enel), le Manifatture dei Tabacchi (all’epoca Monopolio di Stato); per sicurezza di mio padre, i pagamenti venivano effettuati con una trattenuta mensile sullo stipendio effettuata dai Capi del Cral e del Dopolavoro in questione. Inoltre, di quei tempi, non pagare chi ti aveva dato fiducia nel fornirti un buon prodotto e beni di prima necessità, era un vero delitto.
Ma mio padre era specializzato nelle scarpe su misura, specialmente quelle da donna, a mezzo di un fabbricante artigiano di Napoli che veniva ogni sabato Bari, e soprattutto nella vendita delle scarpe di grande misura, insomma dalla taglia 45 in poi per i maschi, per cui mio padre, direttamente o tramite il rappresentante di zona amico suo privilegiato, si avvaleva di un grosso calzaturificio di Piacenza che si chiamava “Diana”, poi conosciuto a livello nazionale e alle croniche sportive perché il famoso podista Dordoni ne indossava la canotta credo di colore misto bianco/verde come si può vedere nella foto qui sotto.

Questa grande marca di scarpa aveva inventato un qualcosa di veramente geniale che impediva alle scarpe, stringate o mocassino senza lacci, di non diventare per c.d. “squandrate” (cioè di allargarsi e diventare di fatto men che pantofole). Infatti aveva inserito nella suola di puro cuoio che parte dal tallone per arrivare a meno di metà pianta del piede, una struttura di ferro leggero a “V” che, appunto, faceva si che i mocassini senza lacci, soprattutto, non si “squandrassero” e diventassero di fatto inutili.
Mio padre e mia madre avevano come amici intimi il dottor Nicola Oberdan Laforgia, un uomo dalla bellezza sconcertante, altissimo, che aveva un piede credo n. 46, dalla barba curatissima e bellissima. Mio padre lo chiamava Nino (mai dottor Oberdan) e mia madre sempre dottore. Il dr. Laforgia chiamava mio padre Umberto e mia madre Lina (da Angela, Angelina, Lina come la chiamavano in famiglia) e con il suo carattere gioviale ed effervescente prendeva sotto braccio o meglio Lui dalla sua altezza (mt.1,90 circa) abbracciava e si portava a spasso mio padre e mia madre. E’ inutile dire che i miei genitori erano entrambi pazienti del dr. Laforgia, il quale li riceveva a qualsiasi ora nel suo studio in Via Garruba n. 3 dove era impossibile (ripeto impossibile) pagare la prestazione professionale; così mio padre si “disobbligava”, si fa per dire, ordinando e regalando i mocassini n. 45-46 che il dr. Laforgia non riusciva a trovare nei negozi di Bari.
Ma in quello studio di Via Garruba n.3 (quando non esisteva la c.d. Mutua) e poi successivamente in quello di Bari Vecchia era impossibile pagare per tutti i suoi pazienti che, come noi, attendevano parecchio tempo, perché le sue visite erano vere visite mediche, ma pregne di buone parole, di coraggio e soprattutto da una semeiotica di elevato spessore. Il dr.Nicola Oberdan Laforgia poi era il Primario dell’Ospedale Civile di Grumo Appula (Bari) e aveva consulenze con vari ospedali della provincia di Bari, come ad es. quello di Barletta, incarichi notevoli a quei tempi, a dimostrazione che come medico internista il dr. Nino Laforgia non aveva rivali.
Ma cosa c’entra il dr. Nicola Oberdan Laforgia con gli ebrei di Bari? Vi assicuro che c’entra in maniera notevole.
Nel maggio del 1949, quando l’Italia era affranta dalla tragedia di Superga, in cui persero la vita i campioni del Grande Torino, io, a soli cinque anni, mi ero ammalato di tifo e paratifo ed il dr. Laforgia si recava spesso presso casa nostra, a bordo della sua 1.400 Fiat (era un grande appassionato di auto e di moto oltre che di pugilato; infatti, era nota la sua amicizia con Ciccio Portoghese, che si intensificò quando questi scalò le cariche federali a livello locale e nazionale), ma ci confessò presto che, dopo averci fatto visita, si dirigeva a Torre Tresca e a Carbonara a curare gli ebrei lì ricoverati nell’ex campo profughi, colpiti da malattie varie, portando loro anche vestiti lindi e puliti.
Faccio una breve digressione. Il dr. Nicola Oberdan Laforgia era originario della provincia di Brindisi (credo San Pietro Vernotico), la sua era una famiglia numerosa ed i suoi genitori si erano sacrificati mandandolo a studiare Medicina a Bari. Lui si laureò brillantemente presso l’Università di Bari, la cui Facoltà di Medicina era collocata nell’attuale università a Piazza Umberto. Qui a Bari aveva conosciuto una bellissima ragazza, peraltro appartenente a famiglia famosa e agiata (era la famiglia Scannicchio, se non sbaglio) e l’aveva sposata; da quel matrimonio nacquero 2 figli maschi (ho conosciuto solo Renato, stimato ortopedico). Nicola, quando era ancora un giovane assistente di Medicina, diede soccorso al giovanissimo Graziano Fiore, figlio di Tommaso Fiore. a seguito delle ferite dovute all’agguato del 28 luglio 1943 in Via Nicolò dell’Arca, ma non riuscì ad evitarne la morte, evento che gli aveva toccato indelebilmente l’animo, come confessò al suo amico intimo e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Pietro De Giosa, mio maestro di giornalismo e di vita, e successivamente, negli anni 70 anche a me, con gli occhi velati e tristi (e non era uomo che si abbandonasse facilmente alla commozione e al pianto). Nicola Laforgia fu il capostipite del ramo barese della famiglia, poi vennero Domenico Pasquale Laforgia, famoso Professore in Odontoiatria, Pietro Leonida Laforgia, famoso avvocato civilista e penalista, indimenticabile sindaco di Bari negli anni 90 e poi senatore della Repubblica, l’ingegnere Felice Battisti Laforgia, Sauro Laforgia credo il più piccolo (ma di quest’ultimo nulla di più riesco a ricordare): una famiglia di socialisti riformisti che ha fatto la storia di Bari.
Tornando al nostro argomento, il dottor Nicola Oberdan Laforgia curava, ovviamente in maniera gratuita, gli ebrei che abitavano a Torre Tresca e Carbonara, li vestiva, li curava, anche sotto il profilo strettamente morale, e li aiutava anche sotto il profilo materiale ed economico. Ma il suo impegno non era soltanto verso gli ebrei di Torre Tresca e Carbonara, ma anche quelli del centro di Bari. Infatti vicino al famoso palazzo di Via Garruba n. 3 di proprietà della famiglia Scannicchio, c’era il famoso palazzo di Via Garruba, 63, il Palazzo De Risi sulla cui “memoria transitoria” si sofferma Sergio Chiaffarata, credo un noto medico barese, il quale così si esprime nel suo “Luoghi di memoria barese”: “Chi cammina nel quartiere murattiano di Bari, e incrocia l’angolo di via Quintino Sella con Via Garruba, spesso non presta attenzione a questo edificio di fine ottocento – inizi novecento, in stile neoclassico (tardo rinascimento).Si fermano solo i passanti che attendono al semaforo, si spostano fra gli uffici o fanno acquisti nelle attività commerciali della zona. Raramente si tratta di un osservatore curioso ed attento, perché quest’angolo è un luogo di traffico e di rapido passaggio, per chi vuole lasciare il “centro” di Bari.Sia che siate frettolosi passanti, sia che siate osservatori curiosi, se vi è successo di passare da quelle parti, soffermatevi sull’imponenza di questo palazzo. Essa è dovuta al bugnato del piano terra e, levato lo sguardo verso l’alto, dalla trabeazione aggettante del terzo piano. Ma uno sguardo più attento rivela dettagli, come le paraste che affiancano le porta-finestre con capitelli corinzi, e poi, le decorazioni a rilievo, come le maschere di leone dalla cui bocca scendono festoni con foglie e fiori. Infine, se lo sguardo è quello dell’architetto o dello storico dell’arte, ci rivela anche la particolarità del prospetto del lato di via Garruba, che non è a tre o cinque luci, come nella norma, ma a quattro luci. L’edificio si chiama Palazzo De Risi. Oggi, è composto da due immobili diversi, uno con accesso esterno da via Garruba, n.63 e l’altro da via Quintino Sella n. 181, forse precedentemente comunicanti all’interno. Un palazzo tutto sommato anonimo? Oggi lo è, indubbiamente. Qui non vedrete nessuna lapide. Ma domani, il passante che leggerà le note che seguono, cambierà idea. Palazzo De Risi, infatti, è un luogo di memoria. Lo sappiamo dai documenti, relativi al periodo bellico della seconda guerra mondiale e quello successivo del dopoguerra, che ci restituiscono la storia di un luogo legato alle vicende della città e alla storia della Shoah. Nel 1938, vennero promulgate le leggi razziali fasciste in Italia, un insieme di norme e provvedimenti legislativi contro gli ebrei. «Il censimento degli ebrei – spiega Vito Antonio Leuzzi – conta, nel 1938, a Bari e provincia, 35 famiglie per un totale di 95 persone: 64 italiani e 31 stranieri». Dopo la loro adozione, quasi tutti i residenti ebrei di Bari, per lo più individui o ristretti nuclei familiari, lasciarono la città. Molti ritornarono nelle loro città di origine, del Centro e del Nord Italia. L’unica famiglia che restò a Bari, fu quella dei Levi, composta dal padre Alberto, dalla madre e da due figlie (Anna Maria e Vera). Alberto Levi era troppo importante per il lavoro della ditta presso la quale era assunto, ed anche quando venne espulso dal Sindacato fascista di categoria, non fu licenziato. Nonostante le leggi razziali e la situazione critica, la famiglia Levi cercò di condurre una vita normale. Quando Alberto fece domanda di iscrizione alla scuola elementare per la figlia Anna Maria, ricevette una lettera di risposta dal Provveditorato agli studi di Bari in data 18 ottobre 1938, firmata dal provveditore reggente, nella quale si diceva: «non posso autorizzare a vostra figliuola Anna Maria, appartenente a razza ebraica, ad iscriversi perché ciò è vietato dalla legge». Nel 1939, Alberto venne arrestato e rinchiuso in carcere. Liberato, continuò a vivere con la famiglia in un paese della periferia per tutto il periodo della guerra. L’anno dopo alla famiglia Levi furono sequestrate anche la radio e la macchina da cucire. Una storia tragica, come tante altre in Italia, ma forse meno. Infatti, nell’autunno del 1943, mentre nel resto d’Italia, la guerra, le violenze e le deportazioni proseguirono fino al ‘45, per la famiglia Levi il non aver lasciato la città di Bari, liberata, grazie all’intervento dei soldati italiani agli ordini del generale Bellomo, e, poi, occupata dalle truppe inglesi, rappresentò una piccola fortuna”.
Ma dice il prof. Liuzzi che “durante il ventennio fascista, palazzo De Risi era stata la sede di un gruppo fascista. Nell’autunno del 1943, i locali del piano terra, in seguito anche quelli del primo piano, furono destinati ad accogliere i profughi ebrei in fuga dal Nord Italia e da altre nazioni, ma anche dai campi di internamento liberati dall’avanzata alleata. All’inizio del 1944, Il Consiglio ebraico, composto da Angelo Sullam della comunità di Venezia, presidente della Comunità di Bari; Isidoro Mandler della Comunità di Trieste, segretario; Ermanno Rocca della Comunità di Ancona, Aldo Ascarelli della Comunità di Bologna, Davide Ascarelli della Comunità di Roma; e Alberto Levi, l’unico ebreo già abitante con la famiglia in città, decise di fare dell’edificio di via Garruba 63, la sede della neocostituita Comunità ebraica di Bari”. “Tra gli iscritti alla Comunità, ci sono diversi nomi importanti dell’ebraismo italiano: Aldo Ascoli, Giovanni Terracina, Guido Luzzatti, Mario Fano, Alfonso Russi, Pietro Foà di Firenze, con suo fratello Arnoldo, giovane attore, che animò i programmi di Radio Bari con il ruolo di speaker nella trasmissione Italia combatte.Nel 1944, secondo i dati riportati da Mario Toscano e da Klaus Voigt, la Comunità ebraica ospitò 70 italiani, 795 iugoslavi, 104 austriaci, 158 Polacchi, 80 cecoslovacchi, 38 Tedeschi, 4 romeni, 35 apolidi, 2 Francesi, 6 bulgari, 5 Ungheresi, 1 Greco, 11 Russi, 4 lettoni, 3 Inglesi, 2 Estoni. Circa 1500 persone”.
Ebbene, di ebrei scampati dall’eccidio nazista in tutta Europa, il dr. Nicola Oberdan Laforgia ne curò migliaia, non soltanto con le sue trasferte a Torre Tresca e a Carbonara/Ceglie, ma anche nel suo studio, come appresi direttamente io verso la fine degli anni 60 quando, diventato giovane e alunno del Flacco, mi recavo da lui autonomamente a farmi curare da ipocondriaco che ero, pauroso di tutto quello che mi capitava. E mi accorgevo che erano ebrei quelli che attendevano con me i quali, stranamente per me allora, avevano i nomi di alcune città come Modena, Genova, Ferrara ecc. Poi seppi dai miei professori del Flacco che generalmente i cognomi degli ebrei corrispondevano a quelli delle città, si dice perché assumessero il nome della città che li aveva ospitati, ripudiando i loro cognomi nell’estremo tentativo di sfuggire alle retate naziste e fasciste, ma nessun professore mi ha mai saputo confermare tale teoria, nemmeno il mio professore del Flacco di Italiano e Latino Michele D’Erasmo, appartenente a quel gruppo di audaci che occupò pacificamente la EIAR di Bari, situata in Via Putignani, poi diventata dopo l’8 settembre 1943 Bari Radio Libera.
Ho ritrovato quelle stesse persone, italiani ed ebrei che erano rimasti a Bari, nel marzo 1976 (se non ricordo male), quando morì in giovane età il dr. Nicola Oberdan Laforgia, colpito da un infarto sulle scale di un ospedale in provincia di Bari, non ricordo bene se a Grumo Appula o a Barletta. Ricordo però che la cerimonia funebre si tenne nel pomeriggio presso la Parrocchia Santa Croce di Via Crisanzio, con la Chiesa, peraltro abbastanza grande, piena sino a scoppiare, come del resto la Piazza antistante, occupata da migliaia di persone, tutte visibilmente emozionate, in preda a pianti inconsolabili. Erano tutti i suoi pazienti. Ed io tra di loro, attonito, a piangere. Andava via un grande medico, un benefattore, un autentico amante della vita e della gioia di vivere, amante dell’amore, editore puro de il settimanale “Sette giorni”, che veniva impaginato con l’originale colore giallo, giornale sportivo e non, la cui redazione era di fronte al proprio studio (da dove sono usciti grandi giornalisti, tra cui Andrea Castellaneta, Aurelio Papandrea, che ne era il direttore, mio fratello Vito, Quirino Sforza, tutta gente che ha fatto la storia del giornalismo barese e pugliese), presidente della Società Angiulli di Bari per quasi 5 anni, grande appassionato di boxe, tanto da costituire, assieme a Ciccio Portoghese, nel 1938 l’Accademia del Pugilato, grande appassionato di auto e di motori: insomma, quello che io reputo “un uomo dalla vita inimitabile”.

B)- Storia personale del Dr. Felice Jelpo: mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello ed io.
Come detto, il sono il quarto nato dall’unione dei miei genitori in quel di Carrassi in Via Piave n.58 ; mi hanno preceduto mio fratello Vito (1937), mia sorella Bruna (1939) e il mio fratellino Nicola, deceduto, credo, un anno/due anni prima della mia nascita.
Al n.86 o 88 di Via Piave sulla sinistra andando verso Via Giulio Petroni, aveva la sua abitazione ed il suo studio il dr. Felice Jelpo. Si trattava, e si tratta tuttora, di una palazzina ad un solo piano; l’androne di quella palazzina era abbastanza ampio e noi bambini cercavamo di introdurvici per giocare al pallone, con la palla di gomma color bianco sporco o con quella di pezza, pur stando attenti a non fare chiasso per non disturbare. Era il dr. Jelpo un uomo bellissimo, con dei baffi finissimi non rialzati nella loro estremità, di una eleganza rara, direi unica; era magro e aveva una moglie un po’ in carne, come d’altronde era di moda in quei tempi, che aveva una carnagione bianco/rosa, capelli lunghi biondissimi naturali con boccoli color oro che le scendevano lungo le spalle, quasi per tutta la schiena, insomma una bellezza eterea, bionda, che faceva da contrappeso ai capelli scuri del dr. Jelpo. Quando uscivano dalla loro casa e passeggiavano sul marciapiede di Via Piave verso Corso Sicilia, era ammirati da tutti i passanti. Ricordo che avevano due figlie, più somiglianti alla madre che al padre, la maggiore nata probabilmente alla fine degli anni 30 e inizi 40, mentre la seconda alla fine degli anni 40 e inizi anni 50. Il dr. Jelpo, a parte i valori familiari, era una positiva autorità in quel microcosmo di Carrassi, specialmente Via Piave, e questa autorità gli derivava dal fatto che lui era un ottimo medico, con grande preparazione in medicina generale e specializzazione in ostetricia e ginecologia, l’unico a Carrassi, e -se non vado errato- era anche assistente ospedaliero o universitario. In quel periodo, da prima della guerra e da dopo guerra in poi, lo specialista ostetrico/ginecologo non era di facile consultazione per le ritrosia delle donne dell’epoca, tra le quali anche mia madre. Peraltro i parti avvenivano in casa a mezzo di una ostetrica, Donna Maria Preziosa, che abitava a pochi passi da noi, esattamente in Via Montegrappa. Tutti i bambini e le bambine nate a Carrassi e dintorni erano stati “presi” dalla levatrice Donna Maria, molto abile e molto brava, come testimoniava mia madre dall’alto di suoi quattro parti; ma quando il parto presentava delle difficoltà, interveniva in aiuto il dr. Jelpo, anzi, in realtà, il suo intervento era determinante nella maggioranza dei casi, soprattutto in quelli che giungevano sino al ricovero della partoriente e, quindi, al parto cesareo, all’epoca un’eccezione, generalmente di esito infausto e, pertanto, estrema ratio cui si ricorreva solo quando si trattava di scegliere tra il bambino e la madre partoriente in termini di vita, come mi fu confermato da mia zia Lucia e da mio cugino Vittorio Loseto (repubblicano, braccio destro del Sindaco prof. Dalfino negli anni a venire) e, infine, dallo stesso dr. Jelpo che, fervente ammiratore di mio cugino e del suo essere a disposizione dei poveri e non garantiti, aveva poi trasferito il suo studio e la sua abitazione da Via Piave a Via Armenise n.7, dove poi i suoi pazienti furono trasferiti ad un suo collega, un certo dr. Portoghese.
Tra il dr. Felice Jelpo ed il dr. Nicola Oberdan Laforgia esisteva un file rouge, innanzitutto per la stima che li legava. Anche il dr. Jelpo svolgeva in maniera eccellente la medicina di base; ed anche lui si recava a Torre Tresca e a Carbonara/Ceglie a curare gli ebrei che, lo sottolineo, provenivano come reduci dai campi di concentramenti sparsi in Germania, Polonia e Cecoslovacchia nonché dalle torture esistenti nei paesi balcanici. E lì a Torre Tresca e Carbonara/Ceglie, le donne ebraiche non soltanto venivano curate sotto il profilo ginecologico (le donne ebraiche erano molto più emancipate di quelle baresi/italiane), ma anche sotto il profilo della assistenza al parto, in quanto loro non potevano permettersi il piccolo contributo economico della levatrice, peraltro quasi sempre assente. Quindi, anche il dr. Jelpo prestava il suo un forte contributo senza essere remunerato o venendo remunerato a livelli marginalissimi, solo per il bene dei poveri ebrei scampati alle torture naziste che stanziavano nelle frazioni di Bari in attesa di imbarcarsi per raggiungere la terra promessa, parecchi per ricongiungersi con i loro familiari.
Questi sono i miei ricordi personali, peraltro raccontati un migliaio di volte da mia madre. Non so se al mio parto abbia assistito, oltre alla levatrice Donna Maria, anche il dr. Jelpo tenendo conto che io venivo dopo la morte del mio fratellino Nicola. Mi fa piacere pensarlo. Ma sul mio certificato originale di nascita c’é soltanto l’attestazione della levatrice Donna Maria. Anche se devo riconoscere che, in genere, i dottori specialisti in ostetricia, che all’epoca erano un lusso e, quindi, una eccezione, non apparivano mai formalmente sugli atti.
Voglio concludere la storia del dr. Jelpo, intersecata con la mia esistenza fin da quando ero bambino, poi diventato ragazzo e poi giovanetto intelligente (nel 1958 ero già al Flacco, si respirava libertà, si parlava di tutti gli argomenti senza alcuna remora), con una seria considerazione.
Dagli anni ‘45 in poi, in pieno dopoguerra, Carrassi e Via Piave e tutte le strade del rione abbastanza popolato, non potevano certo dirsi una isola dove regnasse la felicità. Era un mondo estroverso, certamente meno povero di quello di Bari Vecchia, ma comunque povero. I figli nascevano a frotte e mia madre ne era un piccolo esempio: dal 1937 al 1944 quattro figli. Ma mio padre all’epoca (dico, dagli anni 50 in poi) era un benestante sia pure con molti sacrifici lavorativi e, quindi, si poteva permettere di mantenere 4 figli, poi diventati tre per la morte prematura del mio fratellino Nicola. Ma l’aborto non terapeutico che riguardava tutta Bari e non soltanto Carrassi, era l’espediente per chi non poteva permettersi il quarto, quinto, sesto figlio, specialmente nelle famiglie dove solo l’uomo lavorava e, per di più, faceva lavori umili e saltuari. E, quindi, anche a Carrassi operavano le c.d. mammane, che con molta facilità facevano abortire le donne che si presentavano a loro per necessità di fame. Naturalmente non tutti gli aborti andavano bene e sortivano effetti positivi, sicché c’era la necessità di intervento o della levatrice oppure del medico ostetrico. Dai racconti di mia madre né Donna Maria, la levatrice, né il dr. Jelpo risultano essere intervenuti in qualche modo in questa delittuosa pratica o nelle sue conseguenze, in quanto avevano nel proprio DNA il senso della nascita e della vita. Verso la fine degli anni ’50 e a cavallo degli anni ‘60, venne fuori lo scandalo di un bravissimo medico ebreo (di cui non posso rivelare il nome) riportato sulla nostra Gazzetta del Mezzogiorno: si scoprì che dietro la pratica abortiva c’erano si le mammane, che operavano soprattutto nelle zone agricole, ma aiutate da questo medico ebreo che agiva concretamente su tutta Bari e provincia, dove era molto conosciuto. Non seppi come finì il processo a suo carico, ma non credo che avesse alcuna possibilità di venire assolto, non essendo nemmeno all’orizzonte la legge sull’aborto che, come è noto, intervenne molto tempo dopo nel 1978. E così anche Carrassi chiuse la storia abortistica con lo scandalo del bravo dottore abortista ebreo.
C)- Storia personale dell’avvocato Francesco Muciaccia, detto Don Ciccio Muciaccia: il mio amico di ginnasio e liceo avvocato Niki Muciaccia e mio suocero Michele Schino, entrambi abitanti in Largo Adua presso il Palazzo Colonna, ed io.
Alla fine della 3^ media, dopo aver superato brillantemente gli esami (ero il secondo più bravo della mia classe 3^H presso la Scuola Media De Santis, prima allocata solo di pomeriggio presso l’Istituto Giulio Cesare di Corso Cavour ma con entrata da Via Melo, poi definitivamente all’angolo di Corso Cavour con Via Cardassi vicino alla Chiesa del Sacro Cuore nel vecchio edificio dove prima era la sede dell’Inps di Bari), venni sottoposto, volontariamente, ai testi psicologici di attitudine ai quali i miei genitori non soltanto non si opponevano, ma guardavano con curiosità e interesse; infatti, io, il loro figlio più piccolo, dopo mio fratello che frequentava la ragioneria del Giulio Cesare e mia sorella che aveva avuto una brutta e singolare avventura all’Istituto Margherita di Carrassi, frequentato all’epoca solo dalle ragazze, appariva certo bravo, ma un po’ svagato: andava al Cinema Adriatico di Carrassi quasi ogni giorno da solo, a fine settimana stava il sabato e la domenica sotto le coperte a leggere libri di narrativa e di poesie, incominciava ad andare al Lido San Francesco alla Rena con sotto braccio libro e mangiadischi a pile portatile, insomma appariva un po’ strano per quei tempi. Mio padre e mia madre avevano rispettivamente la 5^ e 3^ elementare e come cultura solo la passione per il melodramma (l’Opera, dicevano loro). E io andavo con loro, anche se poi mi scocciavo un po’. Ma i test psicologici diedero una netta indicazione e inclinazione verso gli studi classici e, quindi, l’Orazio Flacco era una scelta obbligata. Da Carrassi prendevamo la filovia n.8 per il Flacco, che si trovava sempre lì sul Lungomare, solo tre studenti. E nella ginnasiale 4^ E, ebbi tra i miei amici Niki Muciaccia fino alla maturità nel 1963 (una storia quella del Flacco che non si può raccontare in questi ricordi che riguardano Bari e gli Ebrei). Di Niki non sapevo nulla, non sapevo della particolare storia di suo padre, che era un grande avvocato civilista e penalista, dal carattere effervescente e brillante, che aveva combattuto e vinto le battaglie contadine come braccio destro di Di Vittorio in Puglia. Con lui ho trascorso i 4 anni e mezzo di università, per poi reincontrarlo nel Tribunale di Bari verso il 1971/1972. Avevo nel frattempo conosciuto suo padre, con il quale, pure nella serietà del lavoro di avvocato, non si poteva che ridere, per le sue continue battute spiritose e non banali. Da morire dalle risate.
Il 31 dicembre 1967 ho conosciuto mia moglie, Rosalba Schino, con la quale poi mi sono fidanzato veramente verso aprile dell’anno dopo. Mia moglie Rosalba è la figlia di Michele Schino, che abitava con la sua famiglia, composta da 11 figli, a Largo Adua n.17. Al n.24 di Largo Adua abitava l’avv.to Don Ciccio Muciaccia con sua moglie Idea, professoressa di scuola media e i suoi due figli appunto Niki e suo fratello più piccolo Aldo, straordinario redattore del Cirano Post. Come ho detto, mio suocero era famoso in quei luoghi perché, tra le tante attività commerciali, era il proprietario del “Piccolo Bar”, all’epoca situato solo in Via Cognetti, e prima all’angolo di Via Abbrescia con Via Cognetti vicino alla cd. Chiesa dei Cappuccini. Quindi mio suocero e tutta la sua numerosa famiglia conoscevano i Muciaccia, Don Ciccio, l’avvocato, la moglie Idea, la professoressa, e i figli Niki e Aldo. E la mia vita dal Gennaio/Febbraio 1968 si svolgeva intorno a quei paraggi, essendo il mio fidanzamento con Rosalba rigorosamente non ufficiale, anche se conosciuto e visto da tutti. Quindi in quel periodo ho conosciuto, per voce di mio suocero, tutta la vita inimitabile di Don Ciccio, le lotte in favore dei contadini e qualcosa di inedito che io ho realizzato veramente soltanto in un secondo tempo quando ero un assiduo “frequentatore” dello studio medico del dr. Nicola Oberdan Laforgia in Via Garruba n.3: mio suocero e, soprattutto, il dr. Laforgia, mi confermarono il grosso impegno di Don Ciccio Muciaccia dal 1944 in poi in favore degli Ebrei che, ospiti a Bari, avevano bisogno di raggiungere la Terra Promessa, lo Stato di Israele che andava a costituirsi con molte polemiche dal 1947 in poi. Era Don Ciccio Muciaccia che da Bari e Monopoli organizzava i barconi per gli ebrei che volevano raggiungere quella striscia di terra affacciata sul Mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, la Giordania a est, l’Egitto e il Golfo di Aqaba a sud e con i territori palestinesi, ossia Cisgiordania (comprendente le regioni storiche di Giudea e Samaria) a est, e la Striscia di Gaza a sud-ovest.
Don Ciccio Muciaccia, ho saputo in seguito, sovraintendeva da Bari a tutti gli imbarchi degli ebrei che riguardavano il Salento. Non so come i barconi da Bari o da Monopoli raggiungessero quella striscia di terra che ho sopra descritto e che si chiama Israele. So una cosa però: che se è stato un miracolo per milioni di ebrei salvarsi dai campi di concentramento e comunque dalle grande torture perpetrate dal nazismo, altrettanto un grande miracolo è stato, per chi ci è riuscito, raggiungere quella terra. Ma so anche un’altra cosa. E cioè se la mia, la nostra Bari è stata la prima e più grande città europea a ospitare gli ebrei in transito per la terra promessa e ad aiutarli nella loro sacrosanta aspirazione, un bisogno di nuova vita (fatti questi che sono attestati dai documenti e dai preziosi studi storici del prof. Liuzzi) questo lo si deve all’opera, alla dedizione, alla cura per i poveri, per i derelitti e non garantiti, di tre uomini che io ho avuto la fortuna, l’onore e il piacere di conoscere direttamente: il dr.Nicola Oberdan Laforgia, il dr. Felice Jelpo e l’avv. Francesco Muciaccia, don Ciccio Muciaccia.
Ma per questi miei ricordi devo ringraziare anche i racconti dei miei genitori perché, come dice Rita Lopez, “ero troppo piccolo perché possa ricordare, oggi, (tutto) come andarono le cose.Ma io so esattamente come andarono le cose, perché me le hanno raccontate migliaia di volte”.
E concludo.
Questa è storia vera, non documentata o poco documentabile, legata a ricordi vivi e non falsati minimamente da banali stimmate da leggenda. E dice e racconta molto meno di quello che è successo. Ed è comunque storia che deve essere raccontata, possibilmente in tutti i suoi minimi dettagli, anche se insignificanti, perché è la memoria storica non consegnata ai libri e che sta per scomparire nel momento in cui stanno per venir meno tutti i superstiti dell’olocausto.
Nicola Raimondo
.
che dire Nicola, solamente e affettuosamente grazie!!