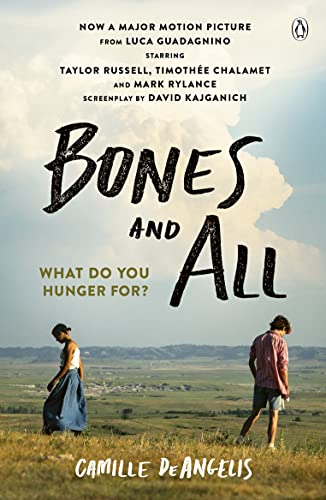
Il cannibalismo è stato da sempre considerato in maniera molto contradditoria, ci sono civiltà che lo hanno praticato anche con finalità religiose o, con l’obiettivo di renderlo più accettabile, riversando nell’atto di mangiare un essere della propria specie significati eroici e di trasmigrazione dell’anima.
In questa parte del mondo, l’antropofagia è sempre stata considerata con un misto di disprezzo e paura. E’ confinata nei racconti del terrore. Quelli di mostri brutali che, mutando le sembianze umane, diventano lupi assassini o altri animali terribilmente feroci e mangiatori di esseri umani.

Luca Guadagnino, per realizzare il suo nuovo film “Bones and All“, ha scelto di adattare il romanzo di Camille De Angelis “Fino all’osso” modificandone alcuni tratti, pure essenziali, e confezionando un prodotto cinematografico nel quale ha riversato una notevole quantità di spunti di riflessione.
Il punto di partenza è l’antropofagismo visto non come atto religioso o comunque eticamente accettabile ma come pulsione interna. Insopprimibile. Come nel romanzo, una giovane ragazza parte in un viaggio alla ricerca dei motivi di quello che la spinge a divorare, in senso non metaforico, quelli che ama. Novella mannara, spinta non dalla luna ma dal mostro dentro di sé, attraversa gli Stati Uniti come una persona ai margini della società; ed è lì che la protagonista incontra altri come lei. La fiutano, l’annusano e condividono con lei le prede. Il viaggio geografico si tramuta in un viaggio nel profondo della protagonista fino alla piena coscienza di sé e all’impossibilità di controllare lo spirito antropofago dentro di lei.

Si ha la sensazione che il regista, utilizzando lo stratagemma del padre che racconta alla figlia quello che è successo (il mitico spiegone utilizzato per aiutare lo spettatore a capire l’antefatto), ci introduca in una dimensione non fisica ma spirituale.
Utilizza l’antropofagia non come strumento fine a se stesso, ma per raccontarci la frontiera, valicata, della società umana di confine che vive di espedienti in periferie banali, sempre uguali, in giornate anch’esse ripetitive perché finalizzate unicamente alla soddisfazione dei bisogni più elementari.

Riadattando la trama il regista, però, in qualche modo modifica l’impostazione del libro (scritto, tra l’altro, da una vegana convinta), utilizzando il viaggio anche per un racconto sociale e non solo un intimo vagabondaggio.
Il racconto si snoda per immagini molto curate, anche quando la luce si fa cruda e leggermente ruvida, tanto da poterla assimilare a quella di Robert Frank e ai fotografi dell’America on the road.
La colonna sonora segue l’impatto visivo del film ed ha momenti di vera bellezza mentre riesce a sottolineare anche l’horror che, comunque, costituisce l’ossatura profonda della pellicola.
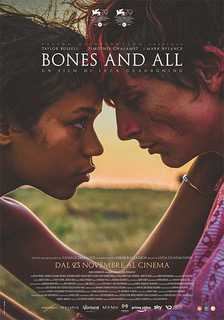
Taylor Russel porta avanti il ruolo in certi momenti apparentemente senza troppa convinzione, ma senza lasciarsi andare a istrionisni di sorta.
Timothée Chalamet è senz’altro convincente e spicca per costanza nella rappresentazione di una disadattata che vive di espedienti, furtarelli e omicidi.
Vi confesserò però, miei cari e sparuti lettori, che purtroppo non sono in grado di comunicarvi uno sguardo complessivo del film, dato che, dopo circa un’ora di proiezione, ho cominciato a guardare il telefono e sono andato via perchè mi stavo annoiando. Ecco: al di là degli ammazzamenti e delle scene di antropofagia effettivamente splatter e rivoltanti, l’appunto che mi sento di muovere all’opera di Guadagnino è che è mortalmente noiosa; solo per questo, mi sentirei di sconsigliarvene la visione.
Marco Preverin