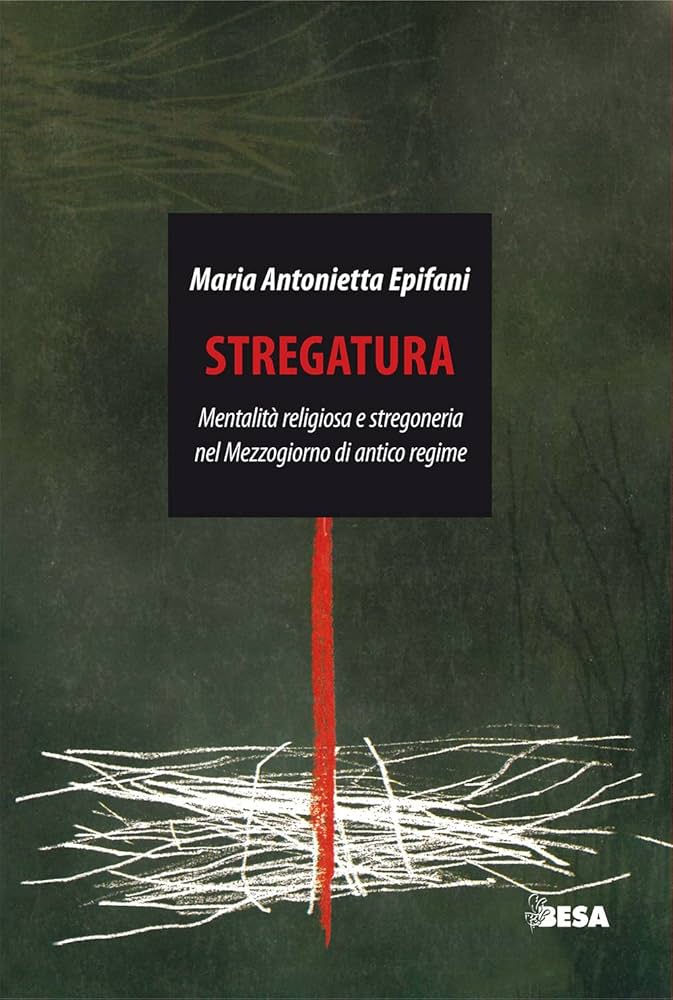
“Il soprannaturale è il tema di fondo di Stregatura che ci guida alla scoperta di una società diversa, dominata dal flagello della povertà e della malattia. Questo lavoro prende spunto dall’analisi di una serie di documenti processuali conservati nell’archivio vescovile di Oria. La divinazione, la medicina popolare, gli incantesimi, le preghiere e i filtri d’amore caratterizzano l’universo magico femminile. Si crede nella loro efficacia perché si tratta di un aiuto altro nei periodi di crisi esistenziale, ma nello stesso tempo è lo spazio elettivo del demonio. Nonostante la “caccia alle streghe”, attraverso cui si è voluto distruggere il pensiero, la libertà, il desiderio e l’appartenenza a se stessi, il soprannaturale sopravvive perché confinato nella dimensione dell’immaginario, universo che non potrà mai essere sottratto all’uomo”.
Questo riferisce Maria Antonietta Epifani nel suo prezioso scritto di circa 180 pagine, frutto di una lunga, meditata e faticosa lettura di centinaia di documenti processuali ancora giacenti e conservati nella Curia Vescovile di Oria (Brindisi). Una lettura certo non facile di questo splendido scritto che ancora una volta coglie la universalità della “stregatura” che certamente non può essere confinata nella sola zona dell’otrantino. E’ la stregoneria una connotazione che contraddistingue non soltanto il Mezzogiorno, ma soprattutto tutti i popoli dove regna sovrana la miseria dei poveri, dei diseredati e dei non garantititi. Diceva Eduardo De Filippo che il “delinquente è cittadino del mondo” cioè non è soltanto appartenente al napoletano. E noi possiamo dire, insieme a Maria Antonietta Epifani, che la stregatura, la stregoneria, la caccia alle streghe, esistono laddove cresce la miseria e la povertà quindi è ancora attuale ed estesa a tutto il mondo.
La stregoneria nella vulgata o meglio nel credo popolare viene vista come un insieme di pratiche magiche e rituali, a carattere prevalentemente simbolico. Tali pratiche, ripeto magiche e rituali, influiscono necessariamente sulle persone o sulle cose che a loro appartengono, e tale influenza la si esercita con l’aiuto del soprannaturale. Ma nel caso della stregatura e/o della stregoneria il ricorso al sovrannaturale avviene a mezzo dell’immaginismo plebeo dei poveri e non garantiti.
Ma la strega cosa è? Cosa rappresenta ancora oggi? Certo viene identificata generalmente in una donna che prevede il futuro e pratica la magia e che, conseguentemente, è in dimestichezza con il diavolo, sicché passa tout court il messaggio di essere considerata come malefica. Di qui il detto famoso, ancora attuale: “Gli (Le) hanno fatto la fattura”. Certo che il ricorso agli incantesimi, alle preghiere e ai filtri d’amore sostituisce il razionale con l’irrazionale e costituisce l’oppio dei popoli dove regnano la miseria e la estrema povertà.
E come dice Maria Antonietta Epifani l’aiuto altro è il sintomo di una grossa crisi esistenziale, che si concretizza in aiuto molto molto diffuso in una esistenza grama che vive ai margini di una società pur sempre contrassegnata dalla povertà dove i problemi si risolvono tout court rivolgendosi alla strega e ai rimedi da lei percepiti ed attuati.La stregoneria è l’attività più vecchia nel mondo, però quando trionfò il cristianesimo le pratiche tipicamente pagane della stregoneria furono identificate come creature infernali e pertanto fu letteralmente bandita e non tollerata ogni e qualsivoglia pratica magica, facendo prevalere il razionale della religione sull’irrazionale della pratica magica.
Mi sembra questo il significato del grande e difficile libro scritto da Maria Antonietta Epifani, dove la stregoneria e/o la stregatura viene tutta declinata doverosamente al femminile perché, a mio parere, i termini sono semanticamente femminili e perché nel vissuto plebeo/popolare la stregoneria e/o la stregatura si identificano nelle donne e nel loro immaginario. Ma l’immaginario delle donne/streghe è si il ricorso per fare filtro, incantesimi, fatture, pozioni e quindi ad un aiuto altro che richiama l’importanza irrazionale dei poveri e non garantiti, dove in buon sostanza esiste e vive una umanità dolente e in crisi di esistenza. Ma nel libro e dai frammenti processuali risulta una stregoneria quasi tutti coniugata al femminile che non richiama solo la semantica, ma qualcosa di diverso.
Il rivolgersi quasi costante e maniacale alle donne, un aiuto altro che rivela un grave gap esistenziale, da una parte rivela la grossa crisi esistenziale, ma dall’altra suggerisce plasticamente che i cd. aiuti altri, che pur sempre sono rivolti praticamente se non prevalentemente, ad una donna, non sono altro che l’abbandonarsi dolcemente alle empiriche soluzioni che solo un donna con la sua delicatezza, la sua delicata sensibilità e con il suo andare oltre, può conferire a chi ne ha bisogno.
Dal ‘300 in poi c’é la cd. stregoneria buona con effetti positivi sull’animo irrequieto della donna o dell’uomo. E la Befana è l’esempio concreto di una strega per cd. buona. Ma é sempre l’immaginario femminile che muove tutto e ancora attualmente nei poli poverissimi dell’Africa, dell’Oriente e del Sud Est asiatico dove il confine tra stregoneria e religione è molto flebile.
E allora toujours chapeau alla stregoneria guidata dal delicato sentimento femminile delle donne.E per finire brava a Maria Antonietta Epifani che con uno studio matto e disperatissimo è riuscita a descrivere un fenomeno abbastanza diffuso anche oggi nei paesi dove regna l’assoluta povertà e marginalità per chi non ha nemmeno un briciolo di pane per sopravvivere alla miseria.
Nicola Raimondo